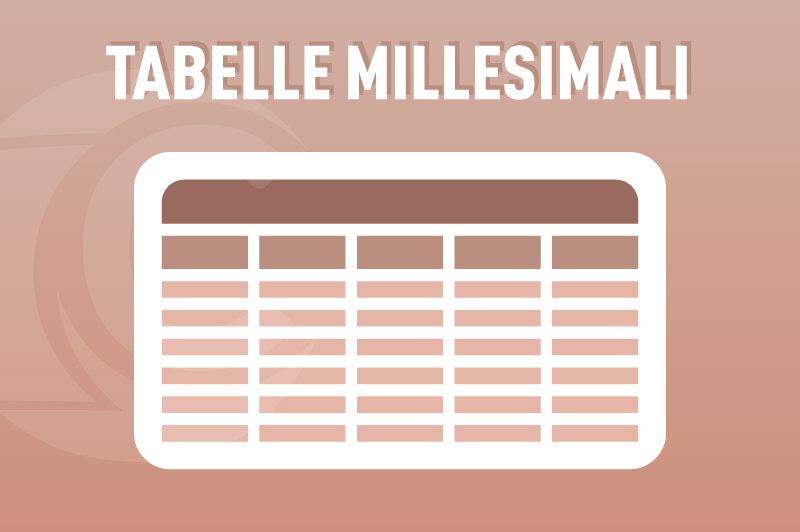Il supercondominio.
Nel silenzio del codice del ’42, il supercondominio è nato, dapprima, ipso facto, perché nelle fattispecie pratiche, si è verificato che “un bene comune fosse a servizio di più edifici condominiali tra loro autonomi” e, successivamente, ha ottenuto riconoscimento giuridico, ipso iure, avendo la giurisprudenza affermato che non occorre nessuna delibera costitutiva del supercondominio, dal momento che, analogamente a quanto accade in tema di Condominio, il supercondominio nasce, ove il titolo non disponga altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condòmini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (così Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32237, annotata da C. Scarpa, Il supercondominio: più condòmini o più condominii?, in Imm. prop., 2020, 300; Il supercondominio dopo la legge di riforma, di G. Bordolli, in Immobili e proprietà, 2013, 8-9, 484 ).
In mancanza di un espresso referente normativo, la dottrina dell’epoca (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e Natoli, in Diritto civile, II, Diritti reali, Torino, 1988, 341) rinvenne il fondamento del supercondominio negli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., norme che – nel disciplinare lo scioglimento di un unico originario Condominio – prevedono che lo scioglimento è possibile anche se restano in comune, tra i due Condomiinii nati in seguito allo scioglimento, alcune delle cose come quelle indicate esemplificativamente nell’art. 1117 cod. civ.. In sostanza, la norma conferma che la comunione di alcune aree e servizi, strumentali al miglior godimento delle unità individuali, non priva di autonomia i singoli Condominii che, seppur connessi per alcuni beni comuni, restano comunque tra loro strutturalmente distinti (anche Cass. civ. n. 11276/1995; Cass. civ. n. 8066/2005, recependo la dottrina, ...